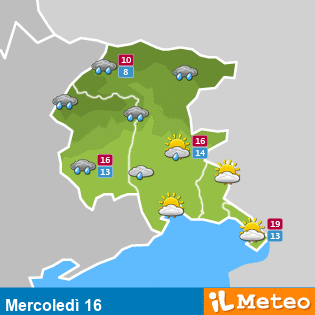Il dibattito sul riarmo europeo è ormai al centro della politica comunitaria

La proposta di Ursula von der Leyen di lanciare il piano “Rearm Europe” segna una svolta importante: da una lunga fase di sotto-investimenti nella difesa, l’Unione Europea sembra pronta a riconsiderare il suo ruolo
strategico nel mondo. Tuttavia, la questione è tutt’altro che semplice. È giusto che l’Europa aumenti le proprie spese militari per rafforzare il proprio esercito e prepararsi a eventuali conflitti futuri, o si tratta di una deriva pericolosa che potrebbe distogliere risorse da settori chiave come il welfare e
l’innovazione?
Chi sostiene la necessità del riarmo parte da un assunto chiaro: il mondo è cambiato, e l’Europa non può più permettersi di essere militarmente debole. La guerra in Ucraina ha dimostrato che la pace, a lungo data per scontata nel Vecchio Continente, può essere minacciata da una potenza vicina e ostile come la Russia. L’idea che Mosca, una volta consolidata la sua posizione in Ucraina, possa rivolgere lo sguardo ai Paesi Baltici o ad altre ex repubbliche sovietiche non è più un’ipotesi da scartare.
Se gli Stati Uniti, con la possibile rielezione di Donald Trump, dovessero ridimensionare il loro impegno nella NATO, l’Europa potrebbe trovarsi sola a gestire la propria sicurezza. In questo scenario, non rafforzare la propria difesa sarebbe un errore strategico gravissimo. Già oggi i paesi europei investono complessivamente nella difesa più di quanto faccia la Russia, ma il problema sta nella frammentazione di questi investimenti: ogni nazione mantiene il proprio esercito, con sistemi d’arma spesso non interoperabili e senza una catena di comando unitaria.
Per garantire una deterrenza credibile, l’Europa deve dotarsi di un esercito più moderno, con una strategia comune e con investimenti mirati all’efficienza, piuttosto che alla moltiplicazione di sistemi d’arma nazionali. Il modello sarebbe quello di una “NATO europea”, capace di affiancare
l’Alleanza Atlantica e di proteggere il continente anche in caso di disimpegno americano.
Un altro argomento a favore è quello economico: un’industria della difesa forte e unitaria potrebbe essere un volano per la crescita europea. Con un piano da centinaia di miliardi di euro, la produzione di armamenti potrebbe sostenere l’occupazione e creare un ecosistema tecnologico avanzato, che andrebbe a beneficio anche di settori civili come l’aerospazio, la cyber-sicurezza e l’intelligenza artificiale.
D’altra parte, chi si oppone alla strategia della von der Leyen mette in guardia dai pericoli insiti in un’Europa sempre più militarizzata. Riarmarsi è una scelta irreversibile: una volta che gli Stati membri avranno aumentato le loro spese militari e costruito un’industria bellica più potente, sarà
difficile tornare indietro.
Il primo problema è di carattere economico. L’idea di finanziare il riarmo attraverso prestiti e con la clausola di emergenza del Patto di Stabilità rischia di pesare sulle future generazioni senza una chiara garanzia di benefici concreti. Inoltre, i Paesi più solidi finanziariamente (come Germania e Francia) avranno più margine di manovra, mentre quelli con vincoli di bilancio più stringenti, come l’Italia, potrebbero trovarsi costretti a deviare fondi da settori cruciali come la sanità, l’istruzione e la transizione ecologica.
Un altro aspetto critico è la questione etica: l’Europa, nata come progetto di pace, deve davvero trasformarsi in una potenza militare? La spesa per la difesa va spesso di pari passo con un aumento dell’export di armi, e già oggi Francia, Germania e Italia vendono armamenti a Paesi
extraeuropei senza un reale controllo comunitario. Si rischia quindi di alimentare conflitti in altre parti del mondo, in nome di una sicurezza interna che non è detto sia davvero minacciata.
C’è poi il problema politico: il piano Rearm Europe non prevede una reale strategia comune sulla difesa. L’idea di un esercito europeo rimane lontana, e senza una catena di comando unitaria e senza una chiara definizione degli obiettivi strategici dell’UE, ogni paese potrebbe usare le nuove
risorse militari in maniera autonoma, aumentando il rischio di tensioni interne.
Infine, l’ascesa dell’estrema destra in molti paesi europei, Germania inclusa, solleva una questione di fondo: chi controllerà questo potenziale militare? Se in futuro governi più autoritari dovessero prendere il potere, avere un’Europa pesantemente armata potrebbe trasformarsi in un
pericolo per la democrazia stessa.
La verità, come spesso accade, sta probabilmente nel mezzo. L’Europa non può permettersi di restare indifesa, ma deve evitare di cadere nella trappola di un’economia di guerra che comprometta i suoi valori e il suo modello sociale. Se il piano di riarmo verrà attuato, dovrà essere
accompagnato da misure che garantiscano trasparenza, interoperabilità tra gli eserciti e un maggiore controllo democratico sulle spese per la difesa.
L’UE dovrà anche lavorare per evitare di diventare un semplice esportatore di armi, introducendo norme più rigide sul commercio bellico e investendo al tempo stesso in politiche di stabilizzazione e mediazione dei conflitti. Il riarmo può essere una necessità in un mondo sempre più instabile, ma
non deve trasformarsi in una scorciatoia per alimentare tensioni o per arricchire l’industria della difesa a scapito dei cittadini.
Se l’Europa vuole rafforzarsi, deve farlo senza tradire la sua natura: quella di un continente che ha fatto della pace, e non della guerra, il suo principio fondante.
Scritto da Stefano Pontoni