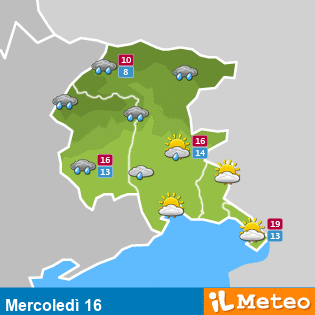Protezione umanitaria, che cos’è e cosa rappresenta. La parola all’avvocato Maddalena Bosio

Il Governatore del Friuli Venezia Giulia, nel corso di un confronto all’ANSA riguardo al problema migranti, ha dichiarato come, per prima cosa, si deve togliere la protezione umanitaria ai migranti, aspetto che esiste solo in Italia. Ha poi sottolineato come le protezioni internazionali sono lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Mentre la protezione umanitaria, introdotta da Prodi nel 2006 è discrezionale, in molti casi basata sulla povertà.
A questa dichiarazione tutti si sono detti assolutamente consapevoli che il “problema migranti” passa proprio da questa “protezione umanitaria”. Ora, partendo dal fatto che non è assolutamente mia intenzione aprire una finestra sulla “quaestio migranti”, troppo corto un giornale per poterla affrontare al meglio, mi sono chiesto quante di queste persone hanno realmente compreso cosa significa e cos’è la protezione umanitaria. Così, per avere un quadro preciso e dettagliato della cosa ho chiesto aiuto ad un esperta del settore, un avvocato. Ho, così, contatto l’Avvocato Maddalena Bosio e le ho fatto una semplice domanda: cosa significa protezione umanitaria e toglierla cosa comporterebbe?
”Cercherò faticosamente di essere breve poiché sarebbe necessaria, in realtà, una lunga premessa storica, culturale e giuridica, ed un’ampissima trattazione dell’argomento.
La cd. Protezione umanitaria, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione (tra le altre sent. 10686/12), è l’istituto che completa il quadro italiano di tutele volto a dare compiuta attuazione al c.d. diritto d’asilo, previsto dall’art. 10, comma 3, della Costituzione. In altre parole, il diritto sostanziale di asilo costituzionale prevede che lo straniero, cui nel suo paese sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, abbia diritto d’asilo in Italia secondo le condizioni stabilite dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Le norme ed i trattati internazionali, per l’appunto, dal canto loro individuano due forme di protezione internazionale (lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria) che, tuttavia, non esauriscono il ventaglio di situazioni riconducibili al concetto di impedimento dell’effettivo esercizio delle libertà costituzionali né possono rispondere a tutte le situazioni astratte e concrete per cui il diritto internazionale impone un obbligo agli Stati c.d. di protezione dalla violazione dei diritti umani inviolabili. In particolare, vorrei richiamare quantomeno quanto con forza affermato dalla Convenzione di Ginevra che all’art. 33 prevede il c.d. principio di non refeulement – per cui gli Stati contraenti non possono espellere o respingere in qualsiasi modo un rifugiato verso confini o territori in cui la sua vita o libertà siano minacciate per i motivi di cui all’art. 1 Conv. Ginevra – e dalla Convenzione Europea dei i Diritti Umani – che, tra le altre cose, all’art. 3 stabilisce che nessuno possa essere sottoposto alla tortura o a trattamenti disumani o degradanti (con conseguente obbligo positivo per gli stati di proteggere i singoli da un tanto).
(La violazione di detti obblighi è valsa all’Italia la condanna nel caso Hirsi e altri c. Italia nel 2012 da parte della CEDU, che con la sua costante funzione interpretativa ha esteso le suddette tutele ai richiedenti asilo ed a qualsiasi contesto di minaccia alla vita e libertà.)
Inoltre, come noto, si è voluto uniformare il più possibile la cornice politica e giuridica dei Paesi Membri dell’Unione Europea al fine di tendere alla costruzione di un Sistema Comune europeo d’asilo e questo fine è stato perseguito anche con l’emanazione di una serie di direttive di portata generale che delineano la sua ‘cornice minima’, nella quale, ovviamente è lasciato ampio spazio per gli stati nell’individuare forme di tutela in ottica ampliativa. Ad esempio, la Direttiva n. 2008/115/CE all’art. 6 prevede che gli stati possano rilasciare al cittadino straniero in condizione di soggiorno irregolare un permesso per motivi ‘caritatevoli, umanitari o di altra natura’. Molti stati oltre all’Italia posseggono (o hanno posseduto in passato) discipline interne del diritto d’asilo che prevedono, magari non nominandolo esattamente ‘protezione umanitaria’ (che anche in Italia è poi il ‘permesso per motivi umanitari’), forme complementari di protezione o permessi umanitari.
L’Italia dal canto suo ha deciso di rispondere agli obblighi costituzionali ed internazionali con il cd. permesso di soggiorno per motivi umanitari che troviamo all’art. 5, comma 6 e 19, comma 1 del D. Lgs. 286/98 e all’art. 32 del D. Lgs. 25/08 (che poi rimanda al primo) che differiscono, sostanzialmente, per il contesto in cui il permesso è richiesto/riconosciuto e per il riferimento come ragione giustificativa del suo rilascio, alla sussistenza di ‘seri’ motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali/internazionali o ‘gravi’ motivi di carattere umanitario. Formulazioni volutamente generali e non tipizzate poiché non tipizzabili sono le situazioni cui sono chiamate a dare risposta, dovendosi qui considerare, ad esempio, la situazione del cittadino straniero inespellibile o non estradabile ma che non possa beneficiare di altre forme di protezione o del rilascio di altro titolo di soggiorno – tra cui si devono considerare coloro che abbiano diritto al rilascio di un permesso di cd. protezione sociale o non estradabili per motivi politici; dall’altro lato i motivi giustificativi del rilascio di detto permesso di soggiorno possono essere riconducibili ai succitati obblighi di protezione, a situazioni di fatto relative al pericolo di violazione di diritti umani fondamentali (es. diritto alla salute, alla sicurezza…), a problematiche ambientali, al diritto ad una vita dignitosa e libera dalla fame. Infine, vorrei ricordare che, ad esempio, il permesso per motivi umanitari è quello rilasciabile alla vittima straniera di violenza domestica.
In tutto questo (complicato) quadro viene, infine, in rilievo la condizione di vulnerabilità della persona, sotto diverse declinazioni tra cui, per l’ambito del diritto d’asilo, anche quella che potremmo definire vulnerabilità complessa, ossia risultante da fattori interdipendenti consistenti in un paese di origine/provenienza in condizione di instabilità/violenza/non rispetto dei diritti umani/estrema povertà e carestia, una vicenda migratoria di fuga, il diritto a vivere dignitosamente e libero dalla fame, che delineano un quadro di contrapposizione tra la vita che, faticosamente, il soggetto sta ricostruendo in Italia, magari con il reperimento di un’occupazione, e la situazione di negazione di diritti ed opportunità in cui il suo rimpatrio lo getterebbe. In quest’ottica viene in rilievo l’integrazione sociale e lavorativa, che, tra l’altro, non viene mai, perlomeno per quanto di mia esperienza, considerata sola giustificazione per il rilascio del permesso in esame, nemmeno dalla giurisprudenza.
Ricapitolando, se domani il permesso per motivi umanitari venisse abrogato si verificherebbe in diritto la violazione su ampia scala di diritti umani fondamentali per categorie del tutto eterogenee non riducibili ai solo richiedenti asilo, nonché una violazione di norme costituzionali ed internazionali, ed, in fatto, la circostanza che una numero non calcolabile di persone non espellibili per divieti assoluti sarebbero costrette ad una permanenza sul territorio priva di titolo di soggiorno regolare, nel completo paradosso e con ogni conseguenza del caso”.